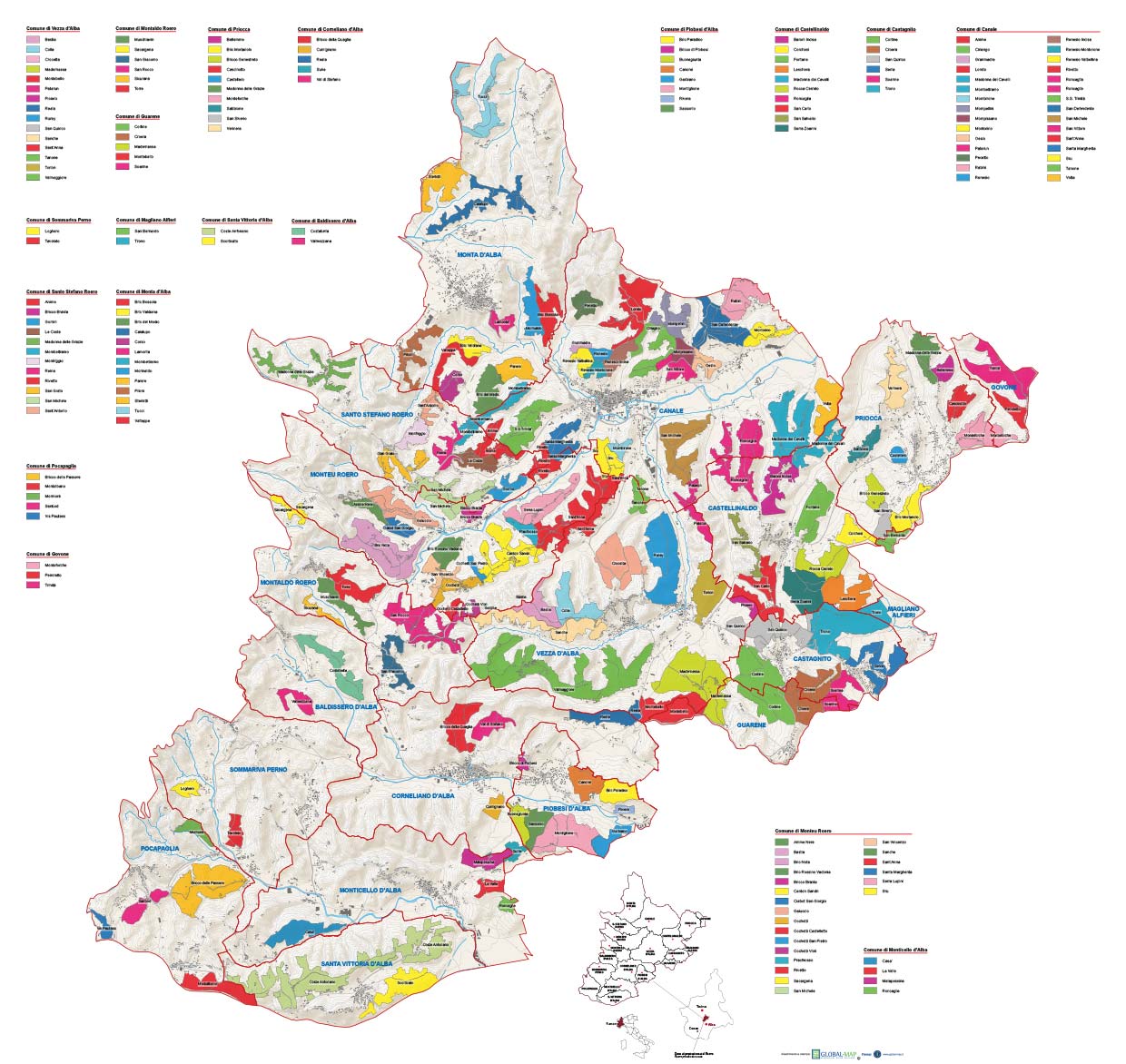Ripercorrere la storia del vino significa scrivere la storia dell'umanità. La vite è stata una delle prime piante coltivate dalle civiltà sumere, assire, babilonesi, egizie e cartaginesi.
Diverse pitture parietali egiziane, risalenti all’epoca imperiale mostrano scene di raccolta e pigiatura dell’uva.
La coltivazione della vite regolava i rapporti commerciali tra l’Egitto e altri popoli che si affacciavano sul Mediterraneo (scambi di grano, vino ed olio), dapprima con i mercanti cretesi e poi con i fenici ed i greci.
La vite europea (Vitis vinifera sativa) appartiene alla Famiglia delle Ampelideae, genere Vitis. La Vitis vinifera presenta due sottospecie: Vitis vinifera silvestris, spontanea e selvatica e Vitis vinifera sativa, ermafrodita.
Le varietà che coltiviamo oggi derivano dalla vite selvatica, modificata attraverso millenni di selezioni ed incroci avvenuti naturalmente e attuati dall’uomo. Sin dalla sua scoperta nella zona del Caucaso, dove sono state ritrovate tracce di coltivazione della vite e di anfore risalenti a varie epoche, comprese tra il 5000 ed il 1000 a.C., il vino ha rivestito, in tutte le società in cui a mano a mano si è diffuso, un ruolo di primaria importanza, in particolare per gli uomini.
Il rapporto vino-donna in quelle stesse società era controverso e basato su una serie di divieti di farne consumo, che potevano comportare estreme conseguenze giuridiche per la trasgredente.
Furono i Fenici a portare cloni di Vitis Vinifera Sativa e il vino in Grecia e poi in Sicilia. La nostra penisola si dimostrò adattissima alla coltivazione della vite, tanto che in poco tempo venne chiamata Enotria, la terra del vino.
In tutta la zona dell’Italia meridionale colonizzata dai Greci (Magna Grecia) vi fu una vera e propria fioritura della civiltà del vino: vicino Sibari venne costruito un “enodotto”, cioè un condotto di argilla che convogliava il vino nella zona portuale dove veniva raccolto in anfore e poi imbarcato.
Nel periodo in cui ebbero a coesistere in Italia la civiltà greca e quella etrusca, tra le due ci fu quasi una frontiera nascosta che differenziò anche le tecniche di coltivazione della vite.

Gli Etruschi tendevano ad accostare la vite ad alberi di medio e alto fusto permettendo così alla pianta di arrampicarsi (pratica diffusa ancora presso Aversa, non lontano da Napoli, per la produzione dell’Asprinio di Aversa, dove la vite è maritata al pioppo, mentre i Greci, le cui tecniche di coltivazione si erano già affinate, utilizzavano sostegni morti (pali di legno). In virtù degli intensi contatti con i popoli del Mediterraneo orientale, dove la cultura viticola era già più evoluta, gli Etruschi poterono affinare le tecniche produttive e importare anche nuovi vitigni di origine orientale (il cui processo di domesticazione erano iniziato in epoca ben più remota nell’area del Caucaso). La pratica di Vite maritata fu sviluppata dagli Etruschi, anche nella parte centro-settentrionale d’Italia. Le viti venivano allevate su pioppi, aceri, olmi, castagni.
Virgilio, nelle Georgiche (29 a.C.) parla della viticoltura della sua terra (Mantova) e racconta che le viti erano maritate all’olmo. In origine le viti non erano potate e tendevano a crescere molto, ad avere tralci lunghissimi. La raccolta dell’uva era effettuata con le mani, con scale apposite appoggiate agli alberi, oppure usando strumenti dal manico molto lungo. La vite maritata è rimasta nella cultura viticola italiana fino ai nostri giorni, in tutti quei territori dove in antichità era arrivata la civiltà etrusca.
In provincia di Avellino si può ancora vedere “La Starseta” o pergola avellinese: viti alte maritate ad alberi e distanziate tra di loro. Tale apparato ha avuto origine a causa degli appezzamenti piccoli e frammentati tra i vari proprietari, e dalla necessità di contenere tutto nella stessa area (viti, orto, alberi da frutta e ulivi).
Gli Etruschi furono grandi navigatori e commercianti. Con la produzione di anfore etrusche da trasporto, vino ed olio divennero beni di largo consumo.
La funzione del vino presso gli antichi Greci si collega principalmente alla parola simposio, dal latino symposium, che trae origine dal greco sympòsion (syn “con” e posis “bevanda”).
Il vino era l’attore principale del simposio, i Greci lo consideravano dono divino, regalato da Dioniso agli umani per porre rimedio ai loro affanni; ne esaltavano i vantaggi e celebravano la felicità che il bere portava, sempre senza abbandonarsi all’eccesso.
“Portami un orcio, ragazzo,
ch’io tracanni d’un fiato,
mescimi dieci misure
d’acqua e cinque di vino,
perché di nuovo io celebri
senza violenza Dioniso
[…]
(Anacreonte)
Il vino rappresentava un particolare momento della vita sociale della Grecia antica. I partecipanti si riunivano per discutere di politica, arte, filosofia, ma anche per scambiarsi idee ed opinioni; si trattava di un luogo in cui si sviluppava la cultura, accompagnando le discussioni con cibo e vino.
Platone (che al simposio ha dedicato uno dei suoi dialoghi) racconta che una coppa di vino veniva passata in cerchio perché ogni commensale potesse berne un sorso e brindare.
Un vero e proprio rito, scandito da atti programmati in anticipo con una forte dimensione religiosa, oltre che relazionale e culturale; il vino non era solo la bevanda che procurava sollievo agli uomini, ma un mezzo attraverso il quale l’uomo entrava direttamente in contatto con gli Dei.
I Greci deploravano l’ubriachezza, la consideravano non degna di un uomo civilizzato, evitarne le conseguenze negative era fondamentale!
Tra l’altro il vino puro della Grecia era molto alcolico, non a caso veniva sempre servito con acqua, talvolta si aggiungevano miele e resine, che lo rendevano più stabile e più adatto alla conservazione e al trasporto.
Al simposio non era ammessa la presenza delle donne...salvo alcune eccezioni: le etère, che suonavano l’aulòs e danzavano.
Anche nella cultura dell’antica Roma, a tutte le donne era rigorosamente vietato bere vino e la trasgressione di questo divieto era punita con severità: lo storico Valerio Massimo racconta che un cavaliere di nome Egnazio Mecenio uccise a bastonate la propria moglie solo per averla trovata ubriaca. Secondo la moralità del tempo il bere vino conduceva le donne direttamente all’adulterio: per gli antichi si trattava quindi, di una pratica che poteva nuocere alla purezza femminile.
Dionisio di Alicarnasso, narra che Romolo stabilisce questa regola poiché “l’adulterio è origine di follia e l’ubriachezza è origine di adulterio“.
Solo nell’età imperiale fu concesso alle donne di bere il vinum passum, cioè il vino passito, e in genere i vini dolci.
Al modello della “pudica e domiseda matrona romana”, che viveva all’ombra del focolre domestico, si contrappone la più libera donna etrusca: raffinata, elegante ed indipendente. Il benessere economico della società etrusca faceva sì che, già in età arcaica (dal VI secolo a.C.) le donne cominciassero ad “uscire” dalle mura domestiche per partecipare in maniera sempre più attiva alla vita pubblica.
Dunque, trascorrevano molto tempo in società, partecipavano a eventi mondani, gare sportive e spettacoli. Nelle scene raffigurate in numerosi affreschi, le donne etrusche sostenevano lo sguardo degli uomini, senza arrossire. Nel mondo romano antico, il vino era il rimedio agli affanni, Orazio ricorda che dà anche libero sfogo ai sentimenti nascosti.
Per i romani era piacevole lasciarsi trasportare dai piaceri del vino che, scendendo nelle vene diffondeva nel corpo una gradevole sensazione di ebbrezza, che contribuiva a creare speranze e ad allontanare preoccupazioni, tensioni e malinconie.
La civiltà Romana è stata la civiltà chiave nello sviluppo del vino in molti aspetti. I Romani possono essere considerati i padri della regolamentazione giuridica (introdussero il diritto di proprietà della terra, garantendone i confini attraverso il catasto e la centuriazione), del commercio del vino e della moderna viticoltura, con la crescente consapevolezza della vinificazione, anche se le prime influenze sulla viticoltura della penisola italiana possono essere fatte risalire agli antichi Greci e agli Etruschi. Nelle mani dei Romani, il vino diventa democratico, disponibile per tutti, dal più basso schiavo al contadino e fino naturalmente all’aristocratico.
Di fatto il vino era una necessità vitale per i romani, lo bevevano tutti i giorni. Si “pasteggiava” con il vino, lo si abbinava alle pietanze. L’antipasto tipico (gustatio) comprendeva uova, olive, frutti di mare, verdure ed era innaffiato di mulsum, il vino mielato.
Questo spinse a diffondere la viticoltura e la produzione di vino in tutte le zone dell’impero, al fine di garantire un approvvigionamento stabile per i soldati romani e per i coloni.
I Romani amavano molto l’odore di vino e sperimentavano diverse tecniche per migliorarne il bouquet, come piantare erbe (lavanda e timo) nei vigneti, pensando che i sapori si sarebbero trasferiti, attraverso il terreno, nell’uva.
Naturalmente il vino di qualità migliore era riservato alle classi superiori di Roma. Il vino più prestigioso era il Falernum che si distingueva per la sua capacità di invecchiamento. Fu il più famoso vino prodotto nell’antica Roma, venduto in tutto il mondo, anfore di Falernum venivano inviate in Britannia, Gallia, Hispania, Cartagine ed Alessandria d’Egitto.
Fu il vino offerto da Cleopatra a Cesare dopo la vittoria.
Nelle rovine dell’antica Pompei è stato trovato un listino prezzi sulla parete di un termopolio che dichiara:
“Per un asse puoi bere vino
per due assi si può bere il migliore
e per quattro può bere Falerno”
Pompei era uno dei centri vinicoli più importanti del mondo romano. L'area era sede di una vasta distesa di vigneti e fungeva da importante città commerciale con le province romane all'estero oltre ad essere la principale fonte di vino per la città di Roma.
Plinio il Vecchio, nel suo Naturalis Historia scriveva che la coltivazione della vite, aveva una tale supremazia da superare le ricchezze di ogni altro paese.
Opere di altri scrittori romani classici, in particolare Catone, Columella, Plinio, Orazio, Palladio, Varrone e Virgilio, fanno luce sul ruolo del vino nella cultura romana, nonché sulle pratiche vinicole e viticole contemporanee.
Sia Plinio il Vecchio che Columella offrono un quadro preciso dei vitigni sviluppati nel corso del tempo dai Romani. La grande varietà di tipologie di arbusto ( Plinio ne conteggia più di 160), si divideva principalmente in vitigni nobili et ignobili, ovverosia in vitigni di grande qualità e vitigni dalla produzione massiccia, ma di basso pregio.
Il “De re rustica” di Columella è da considerarsi un trattato di agronomia del primo principato (Columella morì nel 70 d.C.) arrivato a noi completo. Alcune di queste influenti tecniche si possono trovare nella vinificazione moderna.
Questi includono la considerazione del clima e del paesaggio nel decidere quali varietà di uva piantare, i benefici dei diversi sistemi di allevamento della vite, gli effetti della potatura e delle rese del raccolto sulla qualità del vino, nonché tecniche di vinificazione come l'invecchiamento “sur lie” dopo la fermentazione e il mantenimento delle pratiche igieniche durante tutto il processo di vinificazione per evitare contaminazioni, impurità e deterioramento. Avevano intuito anche l’importanza della temperatura nel corso della vinificazione.
L’economia trasse giovamento da questo settore in continua espansione e i mercanti romani colsero le opportunità di scambi commerciali con le tribù native delle terre conquistate, in particolare con i Galli e gli Spagnoli.
La capacità di invecchiamento era una caratteristica molto apprezzata dei vini romani e di conseguenza le annate vecchie raggiungevano prezzi molto alti.
I vini invecchiati (quelli che avevano passato l'estate successiva alla data di produzione) erano esaltati sulle tavole dei ricchi Romani, i quali li ostentavano nei loro banchetti.
Un’altra tecnica largamente praticata era quella di affinare alcuni vini in anfore, in soffitte dove veniva convogliato del fumo, dette fumarium, per conferire un aroma di affumicatura.
Verso la fine del I sec. d.c., l’anfora iniziò ad essere sostituita dalla “botte”, trasportabile anche da due soli uomini e caricabile sui carri. Il Nord Italia e l’Europa Occidentale sede delle cultura celtica erano grandi fabbricatori di botti e una cronaca romana di Vitruvio riferisce che l’imperatore Massimino, attraversando l’Isonzo, con le sue truppe costruì un ponte di fortuna legando insieme migliaia di botti.
Nell’antica Roma esistevano già locali dove mangiare e bere vino, si chiamavano taverne o anche popine.
L’ambiente era molto grande e vi erano tavoli dove le persone potevano mangiare sedute. Le taverne erano fumose e spesso sudice, ma offrivano qualche piccolo intrattenimento alla clientela.
Durante i fastosi banchetti dei Romani si rendeva indispensabile la presenza di un esperto, l’“haustores”, potremmo dire il sommelier di oggi, che decideva la quantità di acqua che bisognava aggiungere al vino in base al menù. Talvolta veniva utilizzata anche acqua di mare per rendere il vino meno dolce e meno denso.
I Romani usavano, inoltre, i “tagli” tra vini diversi: un dolce vino greco di Chio, ad esempio, per mitigare l’asprezza del Falerno. La bevanda comunque preferita rimaneva il multimediale, una miscela di miele e vino con cui si aprivano i sontuosi banchetti delle grandi famiglie patrizie.
Riguardo alle donne, sin dalle origini c’è stato il divieto di bere vino (“Mos Maiorum”); anche annusarlo era reato. Una delle prime "leges regiae" (quella attribuita a Romolo da Dionigi di Alicarnasso) stabiliva i motivi per i quali una donna poteva essere condannata a morte su insindacabile giudizio dei parenti stretti o del marito…
Questi poteva esercitare lo "ius osculi", il diritto di bacio; farsi trovare con l'alito pesante poteva significare, per le donne romane, essere vittime dell'etilismo.
A partire dal 250 d.c. iniziò un periodo di decadenza per Roma e anche per la produzione di vino, infatti fu introdotta una tassa che obbligava i produttori di vino a consegnarne una parte all’impero per le razioni dei soldati e per rifornire la popolazione a prezzo politico. Così molti viticoltori cambiarono attività. Guerre civili e spopolamento fecero il resto e, con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, fu a rischio la coltivazione della vite in Italia, solo l’avvento dei monasteri ne comportò la ripresa.
Durante i primi anni del Medioevo, nei territori un tempo occupati dai Romani, lo sviluppo della viticoltura si ebbe in gran parte nei conventi: lentamente si trasformano in veri e propri centri vitivinicoli ad opera di monaci, che sin dall'inizio, si dedicarono alla nobile arte del vino, in quanto elemento indispensabile durante il rito della mensa eucaristica. L'epoca medioevale vide anche un progresso nella qualità del vino; mentre quelli antichi erano quasi sempre tagliati con acqua e resi più gradevoli con l'uso di erbe e aromi, il vino appare nella forma in cui lo consumiamo ancor oggi. I monaci gestirono vigneti monastici, aiutando nella creazione delle qualità oggi esistenti.

In Europa nel Medioevo cambia la figura del “dispensatore delle bevande” che non si dedica più a servire i commensali nei banchetti, ma scende in cantina, dando inizio così alle prime pratiche di organizzazione del servizio. Nei monasteri francesi compaiono due figure quella del “cellier”, un monaco responsabile della cantina, e quella del “caviste” monaco subalterno che si occupa di mescere il vino a tavola.
Nel Cinquecento si mettono in luce nuove figure professionali: gli addetti all’acquisto, alla conservazione e al servizio dei vini. Il “dispensiere-cantiniere”, era responsabile del prodotto dal momento dell’acquisto al momento del consumo. Il “bottiliere” si occupava del servizio del vino e “curava la tavola” Egli, inoltre aveva la mansione di assaggiare le bevande prima di servirle per verificare che non contenessero veleni.
La parola sommelier nasce in Francia dalla parola latina “sagmarium” che indicava il responsabile del trasporto dei vini con animali da soma; termine utilizzato nel Medioevo per poi trasformarsi in Sommelier nel XVI sec. presso la corte del Re Sole.
Dall’Ottocento in poi la funzione del sommelier diviene pubblica con la nascita e la diffusione dei grandi ristoranti.
Il Sommelier oggi è un professionista in grado di effettuare un’analisi organolettica delle bevande al fine di valutarne la tipologia, la qualità, le caratteristiche, le potenzialità di conservazione, soprattutto in funzione del corretto abbinamento vino-cibo.
Si sceglie questo percorso professionale per passione e si apre dinanzi un mondo: il vino è qualcosa di incantevole non solo nel bicchiere. Si programmano viaggi, si visitano aziende, produttori, luoghi, si conoscono persone che ci regalano emozioni. Non è facile da spiegare, ma in un calice di vino ci sono cosi tante cose da scoprire! E più si conosce più la passione cresce. Occorre essere curiosi e non smettere di ricercare. Portare il vino in tavola è una sorta di rituale: aprire correttamente la bottiglia, servire il vino ad una giusta temperatura, abbinare i cibi tipici con i vini che meglio li accompagnano in modo da favorire l’esplorazione del territorio...tutto può amplificare l’emozione di ciò che si berrà.

Le donne Sommelier sono ormai una realtà in crescita esponenziale; l’universo femminile è sempre più protagonista nel mondo del vino: produttrici, enologi donne, sommelier, giornaliste, ristoratrici, buyer...Nel 1988 è nata in Italia ‘L’Associazione Nazionale Le Donne del Vino’ che promuove la cultura del vino ed il ruolo delle donne nella filiera produttiva enologica e della società tutta.
Alle donne si deve anche un rinnovamento nel linguaggio del vino, grazie ad uno spiccato intuito e coraggio verso i cambiamenti. Questo rappresenta un valore aggiunto per tutto il settore vitivinicolo, anche per l’immagine del Made in Italy nel mondo.