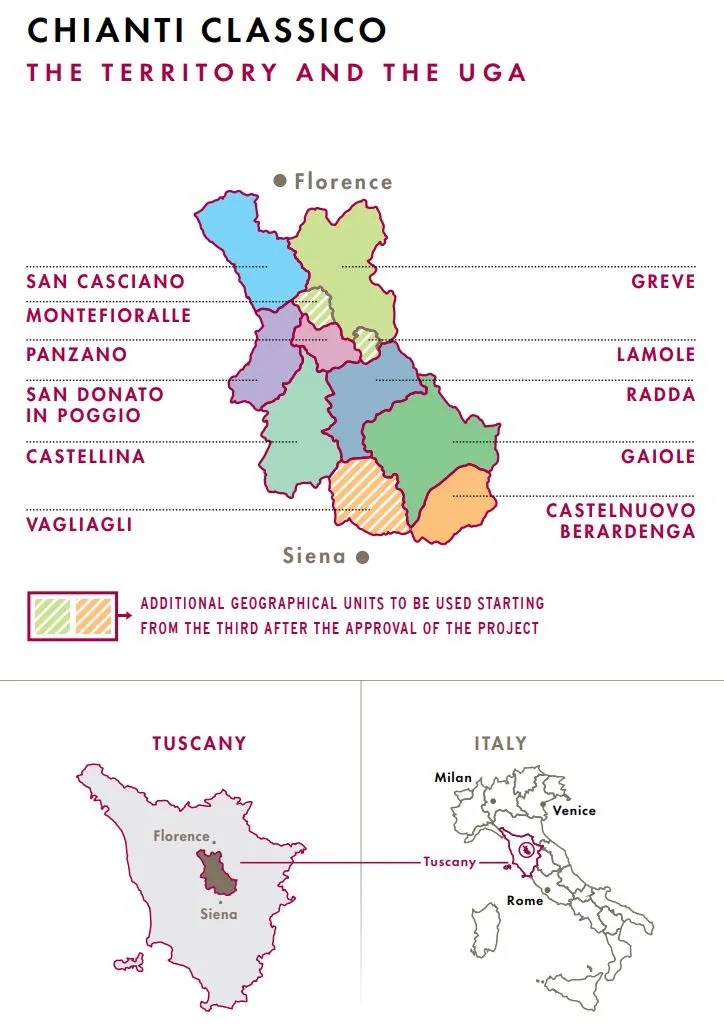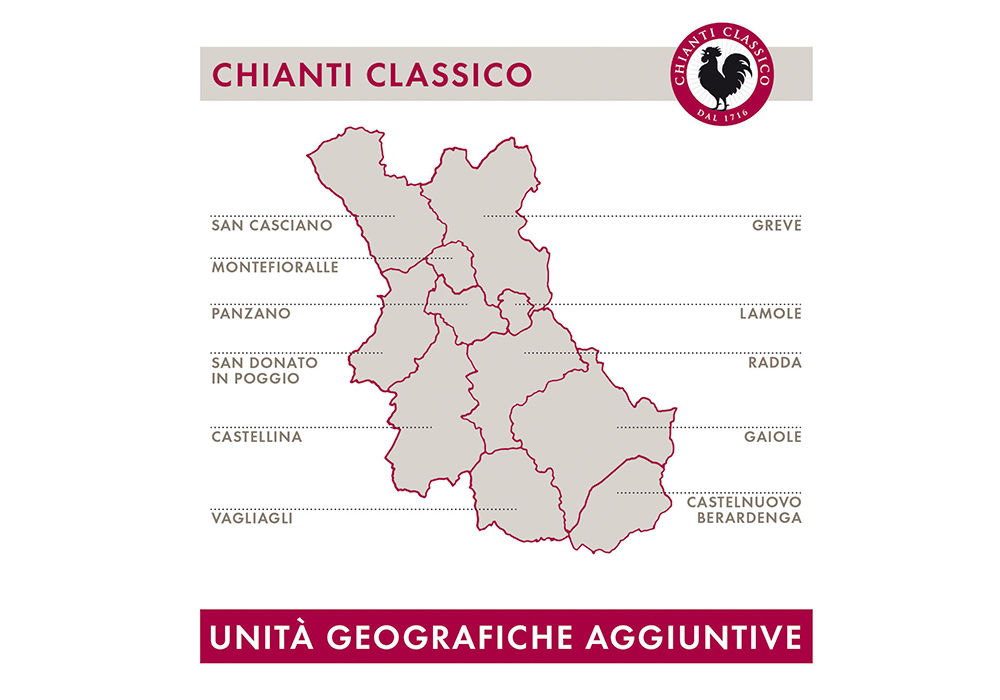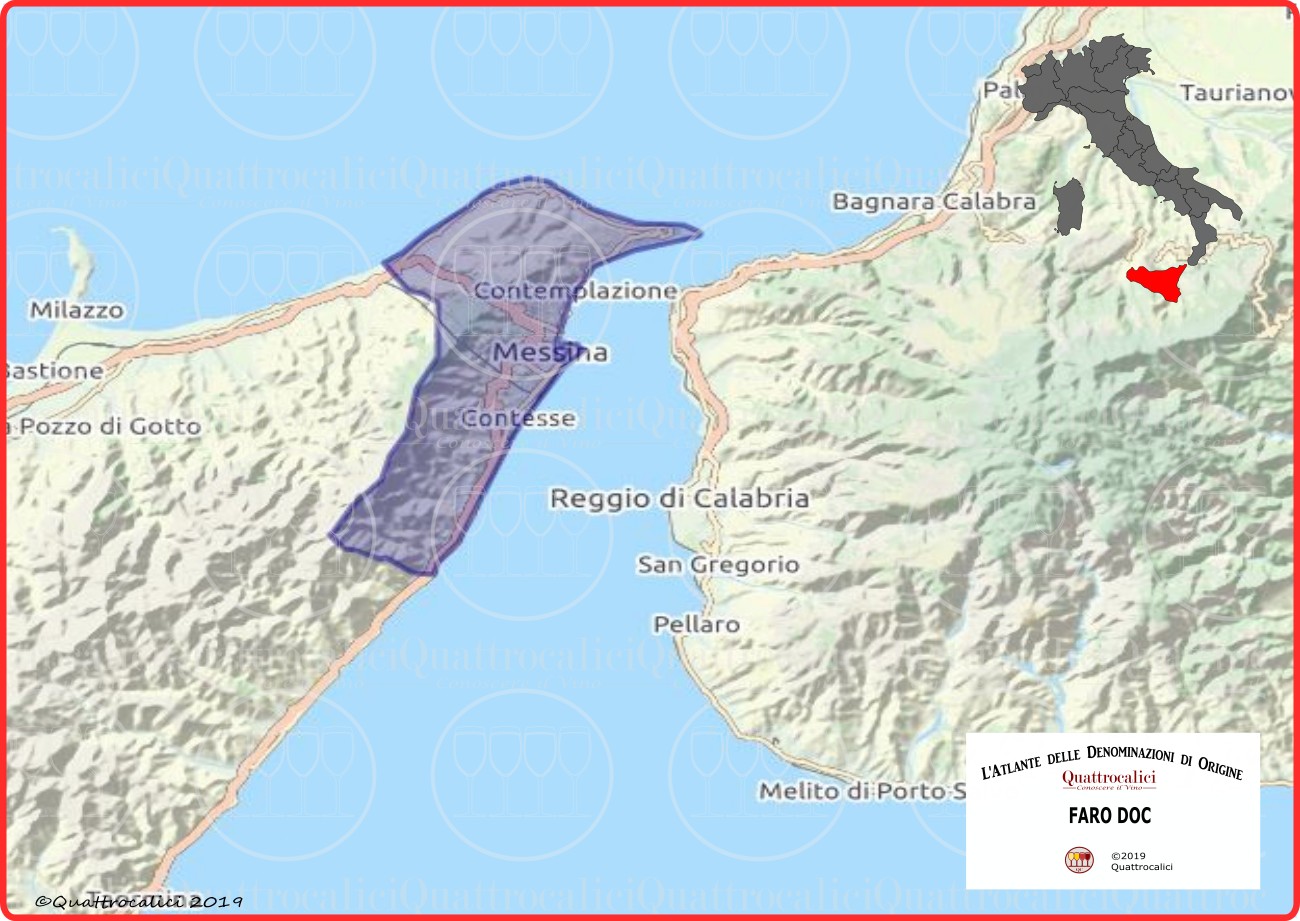di Luciano Pignataro
Prima di encomiare la perfezione assoluta di questo bianco di Angelo Gaja devo raccontare le circostanze in cui l’ho bevuto. Ebbene si, non in uno stellato, non in una enoteca e neanche a casa di un collezionista: mi è stato servito in una pizzeria, precisamente l’Enopizzeria Via Toledo a Vienna di Francesco Calò.
L’ennesimo segnale di una rivoluzione in atto sotto il naso degli stanchi e routinier uffici stampa del mondo del vino che non hanno ancora capito che non solo nelle pizzerie è in atto una forte tendenza al recupero del vino, ma anche dei vini importanti, importantissimi. Basta fare un salto a Confine a Milano, oppure da Allegrio a Roma o da Vitagliano a Napoli per rendersene conto.
Così, per scherzo, chiedo un vino bianco invecchiato che sono da sempre la mia passione, qualcosa che in Italia, anche qui, è assolutamente sottovalutata dalla stragrande maggioranza dei produttori concentrati a fare il rosso più buono del mondo con un panorama ampelografico di uve a bacca bianca da far invidia.
Ed eccoci allora al bianco di Angelo Gaja, devo dire che mi diverte parlare di un vino bianco di un produttore rossista di una regione rossista nella percezione generale delle persone. Alteni di Brassica si chiama così dall’unione delle parole alteni, i piccoli muretti di pietra che delimitavano i frutteti a Barbaresco e brassica, fiore dal colore giallo brillante che fiorisce nei vigneti. Nel dare il nome ai propri vini Angelo è sempre stato un genio. Non solo in questo, ovviamente.
Parliamo di uno dei primi Sauvignon italiani, piantato nel 1983 in epoca pre-metanolo (ricordiamo che è il 1986 l’anno della tragedia). Una etichetta che si produce ancora oggi, sempre con la stessa uva in purezza.
Il vino si è presentato subito in grande spolvero a cominciare dal colore, uno spudorato giallo paglierino ancora vivo e brillante. Non è stato neanche necessario ossigenare il vino più di tanto grazie al suo perfetto stato di conservazione. Il naso ampio e complesso aveva sviluppato note piacevoli di agrume (cedro) ancora mela, della famosa pipì di gatto che fa ridere gli studenti alle prime lezioni da sommelier neanche una traccia. L’asso nella manica olfattivo sono state le note di affumicato e di idrocarburi che il vino ha sviluppato tutti questi anni in bottiglia. Ma è al palato che lo scatto è stato impressionante: non avrei mai detto che si trattasse di ben 17 anni anche perché ingannato dalla vista.
Una clamorosa freschezza balsamica, tanta sostanza e una chiusura infinita, lunghissima, pulita e precisa. È un vero peccato non avere le parole adatte per descrivere precisamente le sensazioni, posso solo parlarvi dello stato di benessere che mi ha abbracciato e disteso sin dal primo sorso. Una bottiglia che ha accompagnato alla grande le pizze in assaggio, comprese quelle più ricche oltre naturalmente alle classiche.
La conferma che con i vitigni bianchi, autoctoni o internazionali poco importa si potrebbe fare un grandissimo lavoro alla pari di zone più famose, proprio come è stato fatto con i vini rossi. Non so se mai vedremo anche questa rivoluzione, nel frattempo li prendiamo, li conserviamo e li beviamo con le persone che ne capiscono.