di Stefano Tesi
Tirando le somme della 23° edizione di "Vinellando", l'evento-concorso dedicato al Morellino di Scansano che ogni terzo weekend di agosto si organizza a Magliano in Toscana, la prima domanda che verrebbe da farsi è: perché, su centinaia di produttori, solo qualche decina decide di mettersi in gioco partecipando a questo pur consolidato appuntamento pubblico (definito dagli stessi organizzatori “nazionalpopolare, ma di qualità”)?
Le risposte possono e potrebbero essere tante. E tutte legittime: sovraffollamento delle manifestazioni legate al vino, calendario incompatibile con altri impegni, esaurimento del budget, periodo feriale, scarsa fiducia nel potenziale promozionale dell’evento in parola o in questo tipo di eventi in generale, aspettative ed esigenze diverse rispetto alla tipologia di pubblico presente, questioni diplomatiche o politiche interne alla denominazione, strategia aziendali o chissà cos’altro.
Io, però, da presidente (ahimè, altrettanto “storico”) della giuria che da sempre sovraintende al momento-clou di Vinellando, ossia il concorso per “il miglior Morellino” e per il “Morellino più tipico” (quest’anno era di scena la vendemmia 2022), mi sono fatto una domanda parallela. E l’ho espressa anche pubblicamente, durante la premiazione. Chiedendomi: cosa ha spinto invece 23 produttori a iscrivere il proprio vino al contest, insomma a mettersi in gioco, in gara, diciamo pure a esporsi, in una circostanza giocata in casa, in un contesto familiare e pertanto, come tale, anche un po’ insidioso? L'ho trovato un gesto di coraggio niente affatto scontato, a ben pensarci. E a cui va dato il giusto riconoscimento.
 |
| Giuria |
La risposta, o meglio le risposte le ho in buona parte trovate già negli assaggi. Tutti svoltisi ovviamente alla cieca, e sotto il vigile occhio di un notaio, dal sottoscritto e dai colleghi della giuria: Filippo Bartolotta, Aldo Fiordelli, Francesca Granelli, Richard Baudains e Riccardo Margheri. Una scelta, quella di un panel giudicante composto esclusivamente da critici, alla quale non ho contribuito direttamente, ma che ho condiviso, perché garante, rispetto al passato, di un’uniformità di metodo – condivisibile o meno che sia – capace di dare indicazioni coerenti. Le stesse indicazioni che, ed ecco la prima delle risposte, i vignaioli in concorso cercavano esplicitamente di ottenere per capire se e quanto la strada da loro intrapresa sia in grado di incontrare il gusto della stampa, quali ne siano invece i punti deboli, su quali le leve puntare per riscuotere riscontri positivi su guide e giornali. L’obbiettivo può apparire ovvio, ma non lo è affatto: primo, perché il criterio di degustazione dei giornalisti è diverso da quello di altre e pur qualificatissime categorie di assaggiatori. Secondo perché, al di là del risultato finale, era proprio l’approccio dei giornalisti ai vini, nel loro complesso e nei dettagli stilistici o tecnici, che ai vignaioli interessava conoscere. Mettendo a fuoco specificità che, in una giuria mista di professionalità diverse come in passato, rischiava di vedersi annullata per compensazione. E quindi di non poter dare indicazioni precise.
Intendiamoci bene: 23 campioni, qualunque sia la composizione di una giuria, non possono certo rappresentare l’intera denominazione e quindi offrire prove di alcunchè sulla medesima. Quindi nessuna velleità in tal senso. Ma alcuni indizi di tendenza forse, sì, li possono dare.
Anche quest’edizione di Vinellando non ha infatti mancato di fornirli: dai calici sono emerse, ad esempio, minori estrazioni, più freschezza, più agilità e al tempo stesso, in modo a volte contraddittorio, il tentativo da parte di alcune aziende (non sempre riuscito, ma questo fa parte del gioco) di mantenere uno stile e una riconoscibilità propri, a volte anche a costo di inseguire modelli meno attuali, ma commercialmente più affidabili nei confronti della clientela consolidata. Il risultato finale è stato, nelle differenze a volte anche marcate tra le diverse etichette, la percezione di un trend condiviso e di un ulteriore rialzo della qualità media rispetto alle precedenti edizioni. Resa evidente non solo dai giudizi individuali, ma dalla classifica finale, dagli scarsi scarti tra i punteggi di noi giurati e dalla discussione di confronto sui campioni che - altro importante elemento di novità rispetto al passato – si è deciso di animare tra una batteria e l’altra.
Non credo sia un caso se, alla fine, si è riscontrata una convergenza piuttosto decisa verso i nomi dei vincitori: al primo posto come “Miglior Morellino 2022” si è piazzato il Podere Poggio Bestiale, al secondo posto la Fattoria dei Barbi, al terzo Il Forteto della soc. agr. Le Rogaie.
Ancora meno casuale il fatto che la palma di “Morellino più tipico” sia andata allo stesso vino vincitore, a riprova che, almeno per i sei degustatori in campo, l'idea della qualità e quella della "tipicità" (concetto volutamente sfumato e che di solito dà il "sale" al confronto) coincidono o quasi. Alla luce di questo, si torna alla domanda iniziale: perché, davanti a un'occasione di confronto come quella offerta da Vinellando e a prescindere dall'intrinseco valore promozionale della manifestazione, su centinaia di produttori di Morellino di Scansano, solo qualche decina decide di mettersi in gioco partecipando a un concorso organizzato sul territorio e quindi, in qualche modo, pure identitario?
Il dibattito è aperto: battete un colpo!


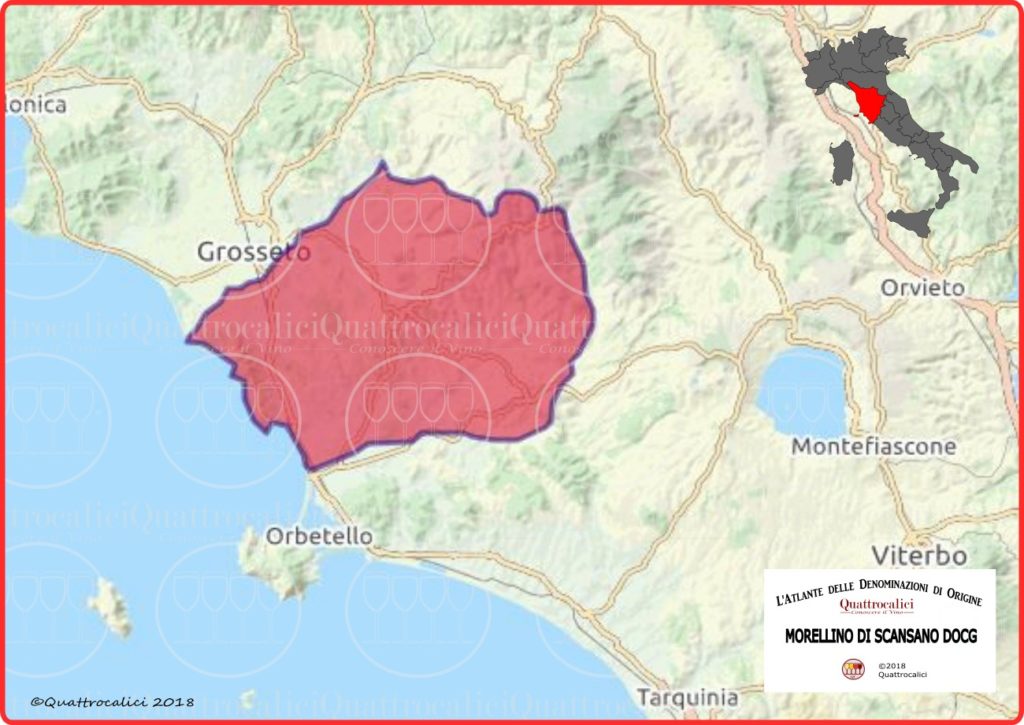

22.jpg)

.jpg)

-2.jpg)
.svg/675px-Map_of_comune_of_Bianco_(province_of_Reggio_Calabria%2C_region_Calabria%2C_Italy).svg.png)





.jpg)
































