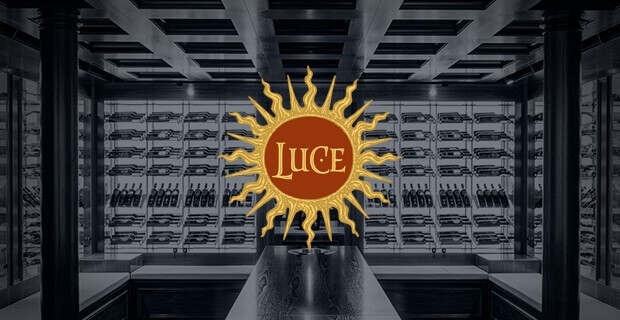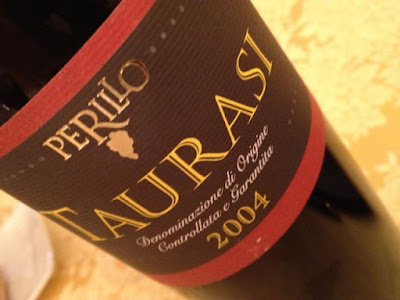di Lorenzo Colombo
Un percorso in cinque tappe quello che ha proposto l’Agraria Riva del Garda lo scorso 14 settembre a Milano, presso il Miele Experience Center.
Cinque tappe culinarie, dove i vini (e gli olii) della Cantina Frantoio, attiva dal 1926, sono stati abbinati ai piatti creati per l’occasione da Alfio Ghezzi, chef che vanta una stella Michelin nel suo ristorante Senso Alfio Ghezzi Mart di Rovereto.
In tutte le preparazioni Alfio ha utilizzato prevalentemente prodotti provenienti dal Trentino e tra gli ingredienti di ciascun piatto troviamo naturalmente un olio dell’Agraria Riva del Garda e lo stesso vino che poi accompagnerà il cibo.
Avevamo in passato già degustato (e recensito) alcuni vini di questa cooperativa ed abbiamo trovato assai gradevole la possibilità di verificarli abbinati alle preparazioni di un grade chef. Ci spiace non poterci esprimerci in merito agli olii non avendoli assaggiati da soli, ma unicamente nelle preparazioni, inoltre non siamo degli specialisti in questo campo, anche se ovviamente riconosciamo quelli buoni.
A proposito degli olii l’Agraria di Riva ne produce diverse linee: Uliva, 46° Parallelo, Ulidea, Imperiale, 1926, Special Edition, Italico, Opera Olei, e, all’interno di queste linnee ci sono diversi prodotti, alcuni dei quali, come scritto sopra, sono stati opportunamente scelti da Alfio Ghezzi ed utilizzati nelle varie ricette.
Ma passiamo a quanto assaggiato ovvero ai vini e relativi abbinamenti:
Cavolfiore, Trentingrana, Peperoncino, Nocciole e Cacao, abbinato a Trento Doc “Brezza Riva” Riserva Pas Dosé 2018 e Olio “46° Parallelo” Blend
Che dire, se non che si tratta del piatto che abbiamo maggiormente apprezzato (unitamente alla Razza Rendena), solo che in questo caso ci eravamo posti un poco prevenuti, visti gli ingredienti, ma vi possiamo assicurare che il tutto si sposava a meraviglia e formava (come dal titolo di un vecchio libro di Veronelli) un “Matrimonio d’Amore”.
Il vino
Il Brezza Riva appartiene alla linea Trentodoc e Bollicine di Riva, che comprende cinque vini spumanti, tra cui tre Brezza Riva: Brut, Brut Millesimato e Pas Dosè, quest’ultimo è il vino che abbiamo assaggiato. Si tratta di un Blanc de Blancs, Chardonnay in purezza le cui uve provengono dalla zona del Lago di Tenno.
L’avevamo già assaggiato in passato, anche se si trattava dell’annata 2016 (qui potete trovare le info che lo riguardano). Sono 2.668 le bottiglie prodotte.
Il suo colore è giallo intenso, al naso cogliamo sentori di crosta di pane e di nocciole tostate mentre al palato lo troviamo cremoso e molto sapido, vi troviamo note tostate e di nocciole, chiude con lunga persistenza leggermente amaricante.
Carote, Abete Rosso e Ulidea, abbinato a Trentino Superiore Doc Müller Thurgau “Vista Lago” Biologico 2021 e Olio “46° Parallelo” Monovarietale.
Piatto in apparenza, semplice, si tratta in fondo di una carota, ma vi possiamo assicurare che anche con un ingrediente così semplice si possono ottenere grandi risultati se lo mettiamo nelle mani di un professionista serio.
Il vino
Il Müller Thurgau abbinato al piatto appartiene alla linea Vista Lago che comprende nove vini (quattro rossi, altrettanti bianchi ed un vino rosa) le cui uve provengono da vigneti montani che godono delle condizioni climatiche date dalla presenza del lago. Altra caratteristica particolare è data dalla forma delle bottiglie che sono le stesse (cambiano solo le dimensioni) di quelle utilizzate per gli olii. Le uve provengono da vigneti situati nell’Alto Tennese su suoli mediamente calcarei, il sistema d’allevamento è il Guyot e la resa è di 90 q.li/ha.
Al Müller Thurgau è stato aggiunto il 5% di Pinot grigio. La vendemmia s’è svolta appena dopo la metà del mese di settembre, dopo la diraspatura e la pigiatura è stata effettuata una macerazione sulle bucce di poche ore, il mosto è stato quindi raffreddato e dopo due settimane è stata avviata la fermentazione alcolica in vasche d’acciaio a temperatura controllata. Anche l’affinamento del vino s’è svolto in vasche d’acciaio dove è rimasto sino alla seconda metà di maggio, quando è stato infine imbottigliato. Le bottiglie prodotte sono state 5.330.
Color giallo paglierino luminoso. Intenso, fresco e pulito al naso dove presenta netti sentori vegetali che rimandano alla foglia di pomodoro ed al gambo di sedano spezzato (ci ha ricordato un Sauvignon). Fresco alla bocca, dove ritroviamo i sentori percepiti al naso, un poco esile di corpo e dalla media persistenza.
Gnocchi di patate e Finferle, abbinato a Trentino Doc Chardonnay “Loré” Le Selezioni 2021 e Olio “46° Parallelo” Biologico
Preparazione piacevole (ci piacciono molto le finferle), forse si sentivano poco le patate negli gnocchi, tanto che abbiamo pensato ci potesse essere del semolino.
Il vino
Il Loré è un vino già assaggiato in passato, si trattava delle annate 2018 e 2019 (vedi qui le caratteristiche). 5.712 le bottiglie prodotte.
Il suo colore è paglierino luminoso. Intenso al naso dove si colgono sentori di frutta tropicale, vaniglia, pasticceria. Mediamente strutturato, asciutto, presenta note vanigliate e leggeri accenni vegetali. In questo momento c’è parso più completo al naso.
Porcini, Salmerino Alpino e Cavolo Riccio, abbinato a Trentino Superiore Doc Pinot Nero “Maso Élesi” Le Selezioni Biologico 2020 e Olio Garda Trentino Dop “Imperiale”
Anche questo piatto ci è piaciuto, anche se il salmerino era un poco coperto dagli altri ingredienti (i funghi prevalevano un poco), qualche dubbio inoltre sull’abbinamento sol vino (anche questo -secondo noi- prevaleva sul piatto).
Il vino
Anche questo vino l’avevamo già assaggiato, si tratta va dell’annata 2018 e ne avevamo scritto nel mese di gennaio di quest’anno (vedi qui per tutte le info).
4.840 le bottiglie prodotte. Dopo aver richiesto una seconda bottiglia (la prima, secondo noi aveva un leggero difetto), ci simo trovati nel bicchiere un vino d color granato luminoso e non molto intenso.
Al naso si colgono i tipici sentori di piccoli frutti di bosco ed una leggera nota vanigliata data dalla permanenza in legno.
Fresco e succoso alla bocca, dove ritroviamo le note vanigliate, bella la sua trama tannica e buona la persistenza.
Razza rendena alla brace, Fagiolino Grisotto e Gorgonzola, abbinato a Trentino Doc Lagrein “Vista Lago” 2020 e Olio Uliva.
Ci è piaciuto molto! Carne tenerissima e succosa, insieme degli ingredienti perfetto. Un grande piatto.
Il vino
Il Lagrein abbinato al piatto, appartiene, come il Müller Thurgau, alla linea “Vista Lago” ed è caratterizzato, esteticamente, dalla medesima bottiglia.
I vigneti sono situati a Pasina, in una zona calda e soleggiata, il suolo è ciottoloso, tendente al calcareo, il sistema d’allevamento è a Guyot con resa di 85-90 q.li/ettaro. La vendemmia s’è svolta il 25 settembre, dopo la diraspatura è stata effettuata una macerazione a freddo per un paio di giorni alla quale è seguita la fermentazione in vasche d’acciaio, l’affinamento del vino è stato effettuato parte in acciaio e parte in botti di legno, dopo l’assemblaggio, avvenuto nel mese di gennaio il vino è stato imbottigliato e lì ha continuato il suo periodo d’affinamento.
Ne sono state prodotte 6.504 bottiglie.
Il suo colore è purpureo-violaceo, intenso e luminoso. Mediamente intenso al naso, dove cogliamo sentori di frutta a bacca scura ed accenni speziati.
Strutturato, un poco piccante (sentori di pepe), presenta una buona trama tannica e ricordi di legno, buono il frutto.
.jpg)








.jpg)


.jpg)

.jpeg)